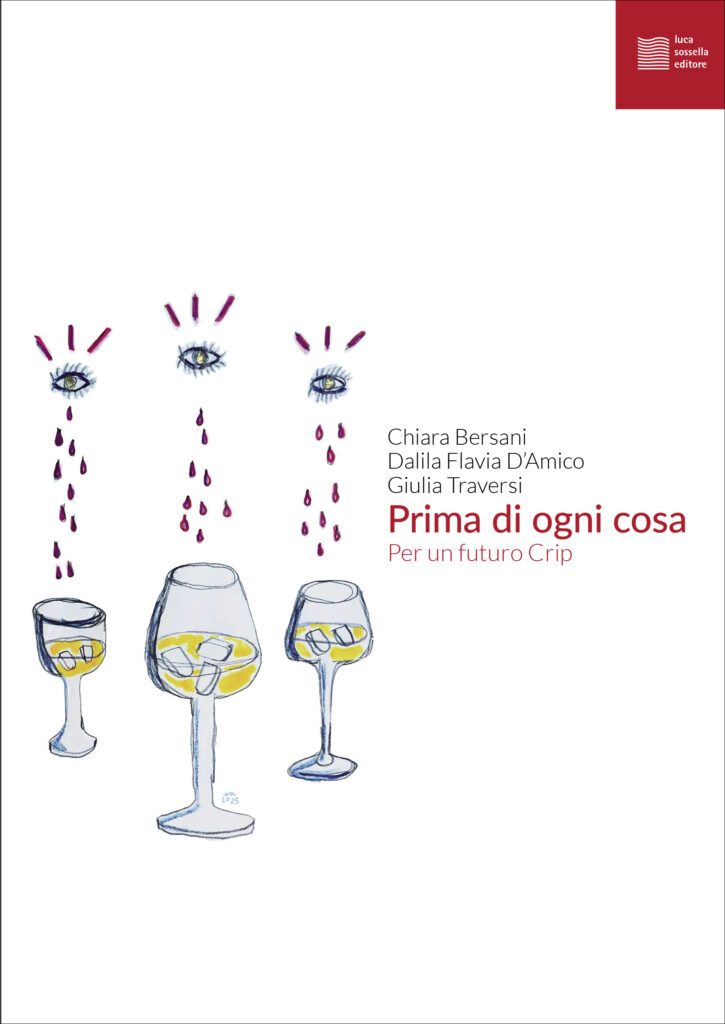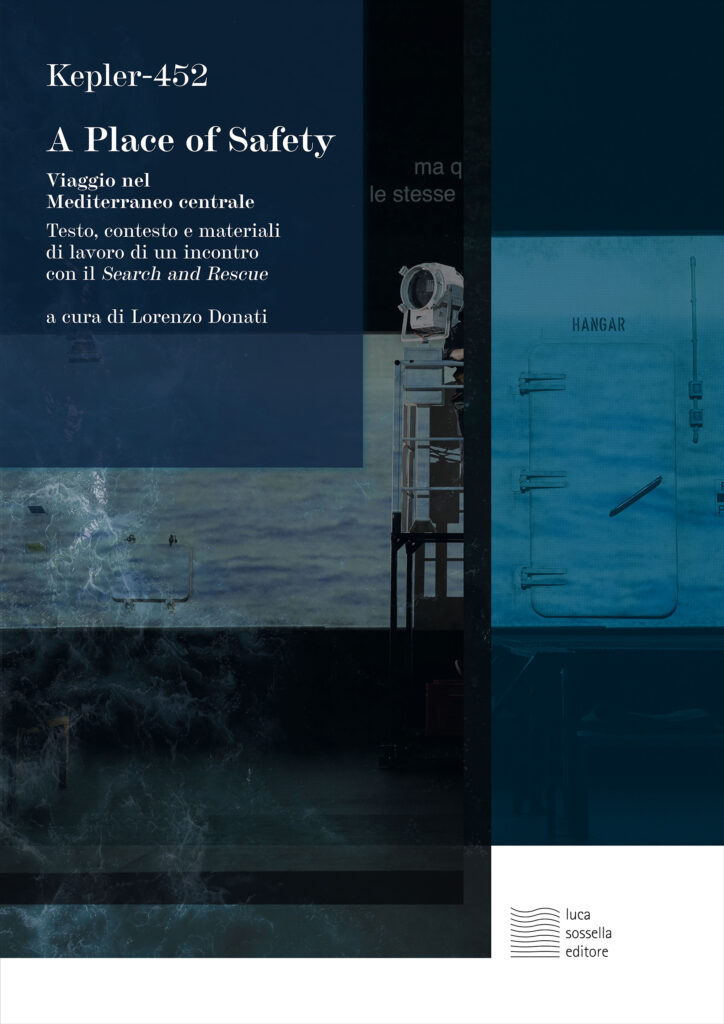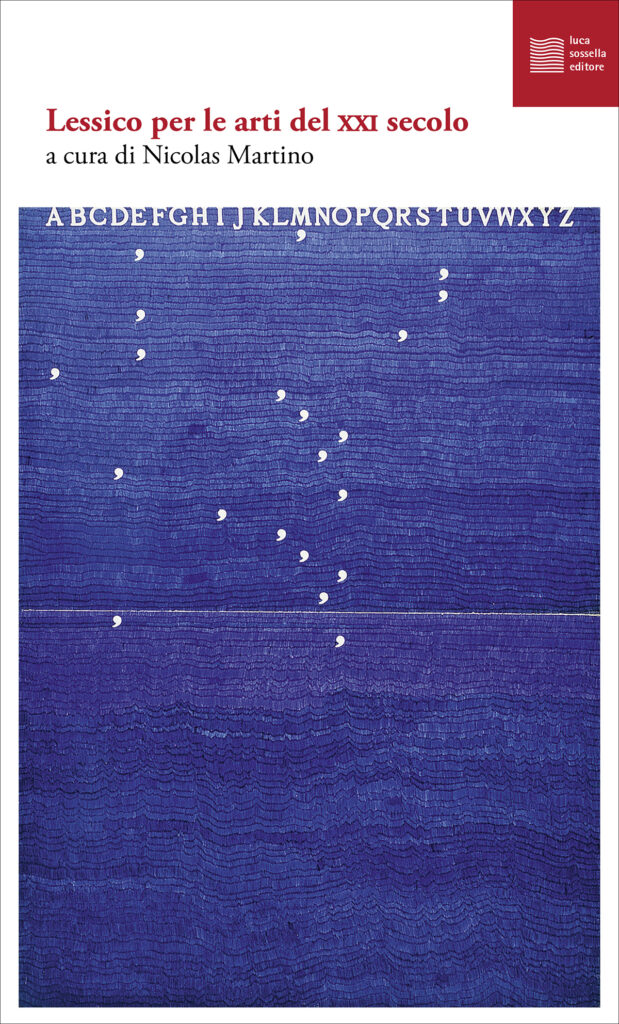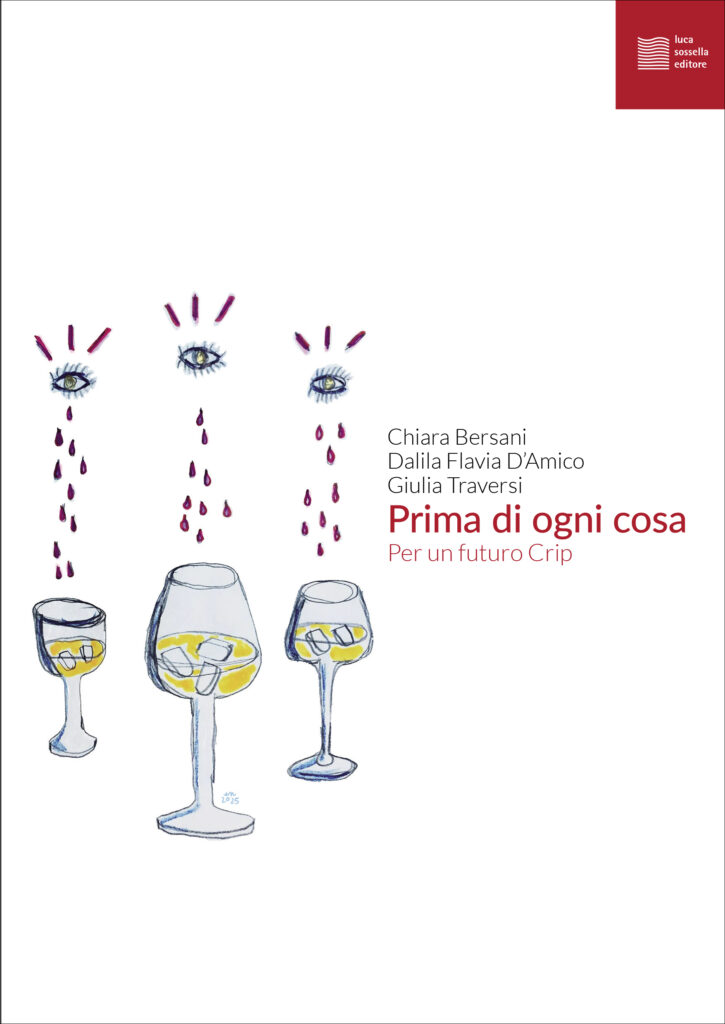Agile Washing! Confesso, la parola non l’ho coniata io. L’ho presa in prestito da una persona che dopo aver visto quattro anni di sforzi in azienda ha capito che l’applicazione di una metodologia Agile ha portato solo ad una finzione e ad un manuale di procedure della metodologia Agile di 29 pagine da seguire alla lettera per potersi definire Agile (lo custodisco gelosamente).
Se però cercate in internet trovate che il termine Agile Washing è più comune di quanto si possa pensare. Non troppo, abbastanza.
Il termine prende spunto dal più noto Green Washing che si riferisce alla pubblicità ingannevole per far apparire un prodotto come ecologico senza esserlo in realtà, ma anche all’utilizzo spregiudicato di alcune aziende delle pratiche di sostenibilità come materiali di marketing per apparire green senza esserlo di fatto, non nelle intenzioni, meno che mai nella pratica. Green Washing, appunto, quando cioè un’organizzazione spende significativamente più in pubblicità “green” che in reali pratiche che hanno un impatto ecologico significativo. Sempre in internet potete trovare addirittura i nomi dei brand che applicano il greenwashing e i relativi esempi.
Forse con Agile non è così marcata la malafede ma la sostanza non cambia, significa dichiararsi Agile senza esserlo per nulla.
Ho anche trovato una vignetta che illustra ironicamente come attivare l’Agile Washing. Mostra una lavatrice e le istruzione per l’uso:
- Inserite un certo numero di Project Manager, Middle Manager, Agile Coach, Scrum Master e persone che fanno parte dei team nel cestello.
- Versate una cospicua somma di danaro nella vaschetta del detersivo.
- Scegliete il programma, ovvero il metodo di vostra preferenza, tra Scrum, SAFe, kanbanboard, Spotify, LeSS, etc.
- Azionate il tasto Kickoff e dopo tre o quattro anni la vostra organizzazione sembrerà Agile ma lavorerà esattamente nello stesso modo in cui lavorava prima.
Agile Washing: come riconoscerlo al primo sguardo
Come però nel caso del green washing esistono alcuni elementi chiave per identificare quando si tratta di pubblicità ingannevole e dichiarazioni fallaci. Per esempio la genericità del linguaggio utilizzato, come per la genericità degli oroscopi suonano bene, si applicano a tutti ma concretamente non significano nulla e non hanno valore legale. Oppure quando fanno dichiarazioni eclatanti su un particolare che sembra green per prodotti che con la salvaguardia dell’ambiente non centrano nulla, se non addirittura sono distruttitivi. Quando vengono usati numeri e percentuali incomprensibili se analizzati. Quando i prodotti vengono ‘ribrendizzati’ cambiando la facciata del packaging o delle etichette ma senza cambiare nulla di fatto. La chiave per capire se si tratta di green washing è in pratica il depistaggio, dichiarare cose che suonano green senza esserlo.
Si tratta in sostanza di mantenere lo status quo apparendo ciò che in realtà non si è. Purtroppo una lunga schiera di certificazioni fallaci danno manforte a queste pratiche poco chiare.
Allo stesso modo per l’Agile Washing esistono elementi identificativi che permettono di comprendere quando un’azienda si dichiara Agile senza esserlo. Non è certo l’utilizzo degli acronimi e del linguaggio che caratterizzano l’agility che fanno la differenza. Il primo fra tutti è come vengono trattati i clienti.
Un azienda Agile è al servizio dei clienti e i clienti se ne accorgono. Un azienda che no lo è, sfrutta i clienti e, talvolta, li vessa con la propria burocrazia interna, pretende cioè che i clienti si adattino e sottostiano a procedure interne, spesso assurde, che l’organizzazione a creato per motivi tutti suoi.
Ricordo un caso di studio in cui si descriveva come il governo inglese nel 2016 spinse la digitalizzazione creando un team multifunzionale il quale lavorò applicando il mindset Lean Agile e al posto di digitalizzare la burocrazia cartacea trasportandola in internet, il team ridisegnò completamente i processi in base all’esperienza che avrebbe fatto il cittadino per renderla agevole e veloce.
Che cosa significa? Significa che l’agility organizzativa adatta i processi e la sua struttura organizzativa alle esigenze dei clienti. Significa anche che una volta impostato il cambiamento, continua a migliorare in base ai feedback che riceve dai clienti, il che implica che debba riadattare processi e struttura organizzativa alle nuove esigenze dei clienti. Questo processo di adattamento viene chiamato business agility.
Sei segnali che Agile è solo una facciata
Ma veniamo agli altri elementi chiave per capire se un’azienda sta facendo Agile Washing. Per osservarli occorre entrare nell’organizzazione per vedere come lavora l’organizzazione. Che cosa si osserva?
- Si riscontra il livello di sicurezza psicologica, se il livello è basso domina la paura e se domina la paura gli errori vengono occultati, se gli errori non emergono non si vedono i problemi e non si lavora sui problemi per risolverli alla radice, l’organizzazione non apprende, non sperimenta, non migliora e non si evolve.
- Poi si identifica se esiste la presenza di ‘pompieri’, eroi che spengono le emergenza senza risolvere i problemi risalendo alla loro causa, le emergenze crescono costantemente sovraccaricando il lavoro delle persone.
- Quindi si osserva il livello di autonomia di persone e team, se è basso, nessuno prende decisioni, nessuno si fa carico della responsabilità, tutti attendono le direttive dei manager.
- Quindi si vede se i manager si comportano secondo il convenzionale mindset di comando e controllo.
- Poi si osservano le pratiche HR di recruiting, di valutazione delle performance e il sistema premiante. Importante sondare il livello di dipartimentalizzazione e la composizione dei team, se interni solo ai dipartimenti o effettivamente trasversali e indipendenti.
- Se poi l’azienda adotta sistemi a matrice per realizzare i propri progetti frammenterà eccessivamente il lavoro delle persone non permettendo loro di vedere il risultato del loro lavoro.
La lista non è ancora finita ma mi sembra già sufficiente. Se osservate questi fattori allora potete tranquillamente sapere che l’azienda che si dichiara Agile non lo è veramente e rientra nella categoria del Agile Washing. E non è una questione di corretta applicazione delle metodologie Agile, come spesso si crede.
Di fatto conosciamo la storia e le modalità di lavoro delle aziende che possiamo definire agili per la loro capacità di adattamento dalla letteratura organizzativa e dai casi di studio accademici. Ciò che accumuna queste organizzazioni sono pochi semplici fattori. Tra questi non appare il fatto che abbiano iniziato da una qualche metodologia ma hanno creato il loro proprio modello operativo, il che lo rende inimitabile, anche se può essere fonte di ispirazione. In queste aziende il modello operativo ha guidato il modello organizzativo e questo è cambiato nel tempo.
Queste organizzazioni hanno spostato decisione e controllo al livello operativo il più basso e delocalizzato possibile. Infine appare evidente che queste organizzazioni non hanno bisogno di dichiararsi agili, lo sono.
🎧 Ascolta il podcast Agile Confidential #LessonsLearned su Spotify.