[disponibile dall’8 ottobre, 208 pagine, 14 euro]
Guerre, crisi energetica, transizione ecologica, intelligenza artificiale: il nostro tempo non è più governato da una linearità prevedibile, ma da onde che si accavallano e generano instabilità profonda, crisi dell’ordine. Imprese e istituzioni hanno bisogno di orientamento: abbiamo leader in abbondanza, ma ci mancano le guide in una navigazione sempre più complessa.
Anima mediterranea di Elena Granata e Andrea Granelli sceglie le onde del Mediterraneo come paradigma: un mare-finestra sul quale si affacciano terre di grande ricchezza e diversità, accomunate da traiettorie che si sono incrociate in un mare da tutti riconosciuto come «nostro». Mare Nostrum è il suo antico nome latino, infatti. Nella geografia culturale a noi più prossima, pensata troppo spesso soltanto in termini continentali e mitteleuropei, occorre con forza ribadire la presenza del Mediterraneo. È un orizzonte capace di generare valori, simboli, colori, sapori, architetture, linguaggi e sensibilità insospettabilmente simpatetiche e armoniche, pur nella differenza delle storie e nonostante la presenza di non poche conflittualità: dalla Spagna alla Grecia, dal Marocco al Libano, dalla Francia all’Albania.
Il Mediterraneo non è un simbolo identitario da difendere, ma un metodo. Ed è il contrario del modello anglosassone dominante: performativo, astratto, accelerato, ossessionato dalla misurazione e dalla scalabilità: il modello che ha colonizzato le business school, gli algoritmi, i manuali. E che oggi mostra tutti i suoi limiti. Il Mediterraneo ci ricorda che la vera capacità di guida sta nel connettere, non nell’opporre. Diventa così una lente per rileggere il nostro tempo in cui l’accelerazione ha prodotto smarrimento; l’iperconnessione, isolamento; la disponibilità infinita di informazioni, ignoranza. La leadership si è spezzata perché ha perso il suo contatto con la terra, con il linguaggio, con le relazioni: il carisma è stato sostituito dalla visibilità, il potere è diventato simulacro.
Se guardiamo al mondo delle imprese, questa prospettiva è tutt’altro che astratta. Le aziende che riescono a prosperare sono quelle che sanno trasformarsi in ecosistemi, mettendo in relazione comunità, territori, stakeholder e tecnologie. Non basta più accumulare dati o moltiplicare indicatori. Occorre allenare quella forma di intelligenza sottile e fluida che i Greci chiamavano metis: la capacità di orientarsi tra contraddizioni e passaggi liminali, di leggere i contesti e agire con misura.
Le grandi piattaforme tecnologiche, dopo anni di crescita illimitata, sono oggi costrette a ripensare i propri modelli di business, integrando nelle strategie la dimensione etica e sociale, in particolare di fronte alle sfide dell’intelligenza artificiale. Il settore dell’energia, chiamato a realizzare la transizione verde, non può limitarsi all’innovazione tecnica: deve costruire mediazioni con i territori, ascoltare le comunità, gestire conflitti e attese. Le imprese manifatturiere italiane che competono sui mercati globali sanno che la loro forza sta nella capacità di radicare l’innovazione nella tradizione, trasformando la cultura locale in valore internazionale.
Granata e Granelli scelgono due figure che hanno incarnato questa forma: Adriano Olivetti e papa Francesco. Olivetti immaginò la fabbrica come spazio di civiltà, molto prima che si parlasse di ESG o di B Corp. Per lui l’impresa non era mai un luogo neutro, ma un’opera d’arte collettiva, capace di fondere bellezza, tecnologia e giustizia. Papa Francesco ha incarnato una forma di leadership profondamente mediterranea: plurale, relazionale, inquieta, attenta alla carne del mondo, praticando nella Chiesa cattolica una governance fondata sull’ascolto e sulla sinodalità, cioè sul camminare insieme, sul valorizzare la pluralità dei punti di vista. La sapienza mediterranea non è quella dell’univoco, ma del molteplice, della complessità che non si lascia ridurre né risolvere. E non è coltivabile senza il contributo delle humanities come l’arte e la poesia, che sanno armonizzare gli opposti. Così è possibile disinnescare alla radice le derive polarizzanti e conquistare un modo di pensare e agire flessibile, umano. Il leader è rimasto oggi una costruzione retorica, un simbolo mediatico. La guida, invece, è presenza reale che sente le tensioni dei contesti e riconosce il peso ecologico e umano di ogni decisione.
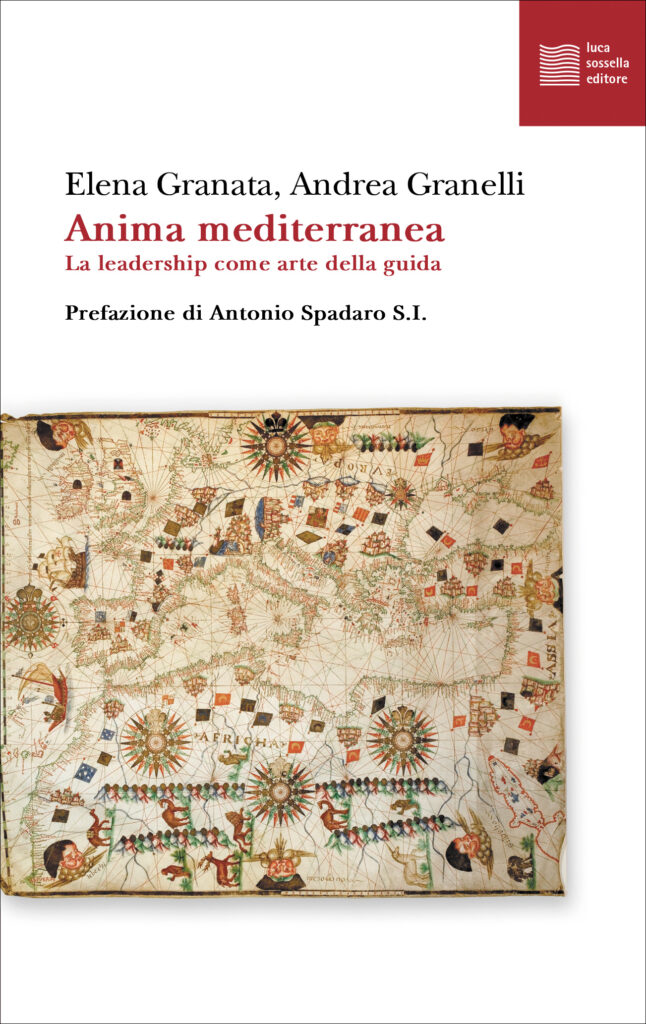
La leadership tradizionale, erede delle business school anglosassoni, ha esaurito la sua spinta: accentra il potere, riduce i rapporti a performance, si affida a strumenti fragili e a conoscenze parziali. Ma un mondo che si muove così in fretta chiede altro. Non un leader che comanda dall’alto, ma una guida che accompagna, custodisce, apre strade. Una guida che intreccia ragione e sensibilità, competenza e ascolto; che mette al centro non solo i risultati, ma il senso, i legami, un futuro condiviso.
Anima mediterranea parte da qui: dal desiderio di guardare alla leadership con occhi diversi, quelli del Mediterraneo. Non semplice categoria storica o geopolitica, ma radice viva e matrice culturale plurale, capace di trasformare la diversità in ricchezza e la bellezza in forza generativa.