Riportiamo qui un brano tratto da Literacy. Semiotica evolutiva dell’apprendimento di Paolo Martinelli.
[disponibile dal 22 ottobre, 304 pagine, 25 euro]
L’ipotesi originale che abbiamo prodotto è quella di una relazione causale tra produzione segnica (nella forma di un percorso abduttivo) ed exaptation neurofisiologica nell’accesso alla lettoscrittura. Questa ipotesi ha il merito di fornire un modello della literacy che è in grado di tenere insieme gli aspetti interni e neurofisiologici e le forze esterne e materiali che concorrono nella produzione del sistema semiotico. È un’ipotesi corroborata dai risultati attuali delle neuroscienze della cultura (riciclaggio neuronale e cultural neural reuse), ed è suscettibile di essere falsificata da eventuali nuovi studi sulla specializzazione delle aree cerebrali dedicate alla lettura.
Sul piano della filogenesi culturale, e in modo del tutto conseguente, abbiamo proposto di ammettere un’origine autonoma della scrittura rispetto al linguaggio verbale. Questa ipotesi – che non è originale ma che dobbiamo in primo luogo a Sebeok (1991) – è confermata dal confronto con gli studi di archeologia cognitiva: se consideriamo gli AMS e le incisioni del Paleolitico come sistemi di scrittura che non seguono un principio fonetico e come precursori di un sistema di scrittura propriamente detto, allora sia la scrittura che il linguaggio verbale sono da intendere come sottoprodotti di un sistema modellizzante primario che è la capacità semiotica di produzione segnica.
Ovviamente la literacy intesa come lo stato cognitivo che ci permette di tradurre in segni scritti il linguaggio verbale si basa su una commensurabilità costruita tra questi sottoprodotti. Questo ci permette di avanzare una considerazione teorica sugli stessi modi di produzione: se nel Trattato di semiotica generale “la teoria dei codici si oppone alla teoria della produzione secondo l’asse ‘significazione’ vs ‘comunicazione’ (Valle, 2017: 319), l’idea in seguito è stata messa in discussione da più parti. Volli tratta questa distinzione come un’opinabile “oscillazione teorica” (Volli, 2015: 35) e lo stesso Valle fa notare che può essere intesa come un artificio metodologico (utile alle esigenze espositive del genere trattatistico) che cela in realtà un superamento della teoria dei codici attraverso la teoria della produzione (Valle, 2017: 320). Da parte nostra, abbiamo voluto mantenere una distinzione tra fenomeni di significazione (a scopo cognitivo) e fenomeni di comunicazione (dove Sebeok indica la seconda come un exaptation della prima), ma abbiamo descritto il funzionamento di entrambi attraverso la teoria della produzione segnica.
Questo è stato possibile perché se intendiamo (come Valle, 2017) il lavoro di riconoscimento alla stregua di un meta-lavoro in cui le forme materiali vengono riconosciute come se fossero state prodotte per ostensione, replica o invenzione (la pietra come utensile) e se la produzione di funzioni segniche per comunicare può prevedere il mittente come unico destinatario della stessa comunicazione, allora la prassi della produzione può essere finalizzata sia a un compito cognitivo che a un obiettivo di comunicazione: da questo punto di vista consideriamo l’allestimento materiale del piano dell’espressione nella produzione segnica alla base dei processi di comunicazione (come nel caso di un bambino che scrive un biglietto di auguri per il papà, o di un archeologo che scrive un articolo accademico da inviare al reviewer) ma non è difficile – come abbiamo accennato – immaginare una situazione in cui si tracciano i segni di un sistema di scrittura per cercare di capire (tra sé e sé) come funziona quel sistema di segni (e questo vale sia per il bambino alle prese con la produzione dei primi grafismi, che per l’archeologo alle prese con un tentativo di decifrazione della lineare a).
Proprio quest’ultima funzione ci sembra essere al centro delle pratiche di apprendimento nel senso in cui sono state descritte in questo lavoro e non valgono, come abbiamo cercato di dimostrare, solo per la scrittura, ma per i più disparati campi in cui è previsto un apprendimento. Proponiamo dunque di mantenere una distinzione tra fenomeni di significazione e fenomeni di comunicazione, pur considerando alla base di entrambi un’attività di produzione segnica che se nel primo caso è intesa a rendere ragione della realtà (scopo cognitivo della produzione segnica) nell’altro è orientata anche alla comunicazione per scopi intersoggettivi.
Se questo meccanismo di produzione segnica per l’apprendimento è perfettamente evidente quando prevede l’ingaggio di forme materiali per costruire (o apprendere) un sistema di segni di natura linguistica, è stato necessario specificare in che senso lo stesso fenomeno si dia nell’apprendimento di pratiche non linguistiche: negli esempi più volte citati dell’apprendimento del nuoto (Deleuze, 1968; Lucangeli, 2019), della categorizzazione dei vini (Festi, 2003; Paolucci, 2007 e 2010) e dell’uso intelligente di strumenti (Eco, 1975; Cuccio e Caruana, 2016) l’asse della comunicazione sembra infatti a prima vista non essere pertinente. Tuttavia la posizione strutturalista di Deleuze e l’idea di lavoro di riconoscimento di Eco inducono a pensare che conosciamo le cose secondo un’ipotesi precisa, cioè prendendo il loro discorso silenzioso, all’atto pratico, come costituito da segni (Deleuze, 1973). Interpretiamo questi segni come fa il destinatario di un messaggio, cioè come se fossero stati istanziati attraverso un lavoro di produzione (per ostensione, replica o invenzione) e correlati a un dato tipo di ratio (cfr. Eco, 1975). Questa attività interpretativa permette di individuare singolarità emergenti (il fonema, l’onda, una sensazione di acidità, una parte della pietra più adatta alla prensione); è l’attività con cui combiniamo i punti singolari del corpo o della lingua con quelli di un’altra figura (cfr. Paolucci, 2010: 235). Che la forma e le caratteristiche materiali di una pietra siano state prodotte da qualcuno per permetterci di includere la pietra nei nostri schemi sensorimotori con l’obiettivo di spaccare una noce è sicuramente un’ipotesi falsa ma, del resto, una delle forze che abbiamo visto agire nella produzione segnica è proprio la forza del falso.
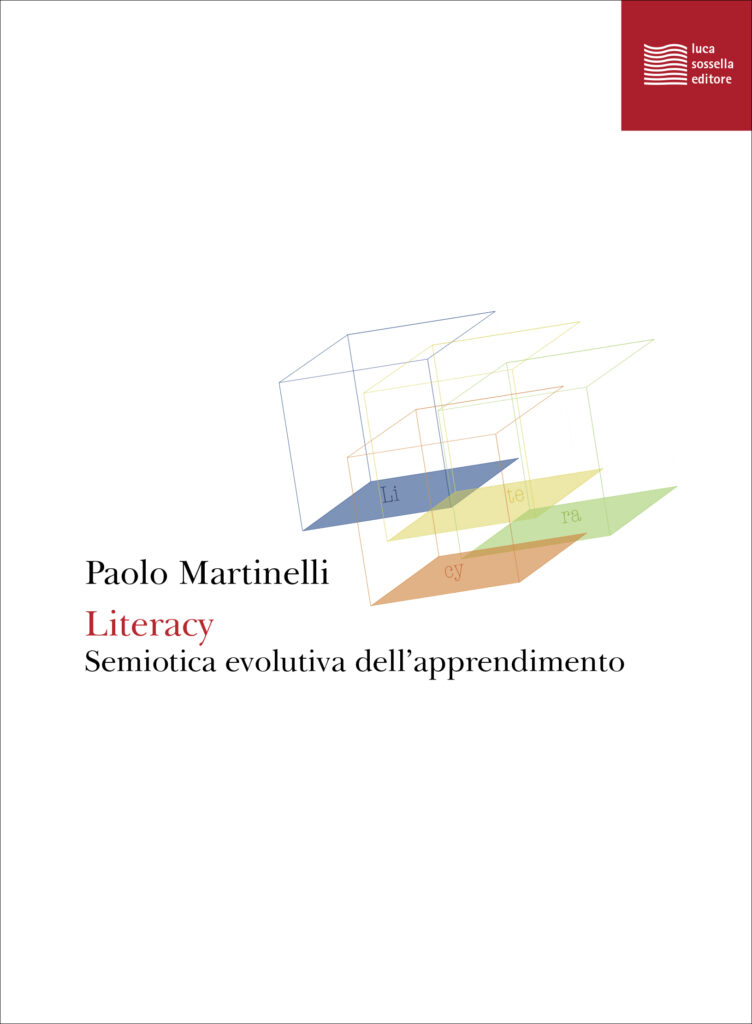
Literacy è quello stato cognitivo che ci consente di accedere al senso delle cose in modo automatico e senza esitare, come quando leggiamo un romanzo e non abbiamo nessun dubbio sul suono da associare ai segni alfabetici che compongono le parole, anzi, non li vediamo nemmeno.
Ogni literacy nasce da un percorso di apprendimento fatto di tentativi e revisioni: come imparare a leggere e scrivere, orientarsi in una città straniera o sentire le prime note con il solfeggio. Sono percorsi evolutivi, perché trasformano sia l’individuo, sia le culture, modificandone le traiettorie di sviluppo.
Lo vediamo bene oggi, quando nuove competenze, come quelle digitali, riscrivono la nostra enciclopedia culturale.
Questo libro mette in luce che la semiosi è alla base di queste forme speciali di apprendimento, che sono in grado di rendere trasparenti i segni e automatiche le nostre interpretazioni.
Attraverso la rilettura di concetti chiave della filosofia del linguaggio, della linguistica e delle neuroscienze, la semiotica evolutiva dell’apprendimento offre un modello capace di tenere insieme “gli universi apparentemente disparati del significato umano e delle scienze naturali”.