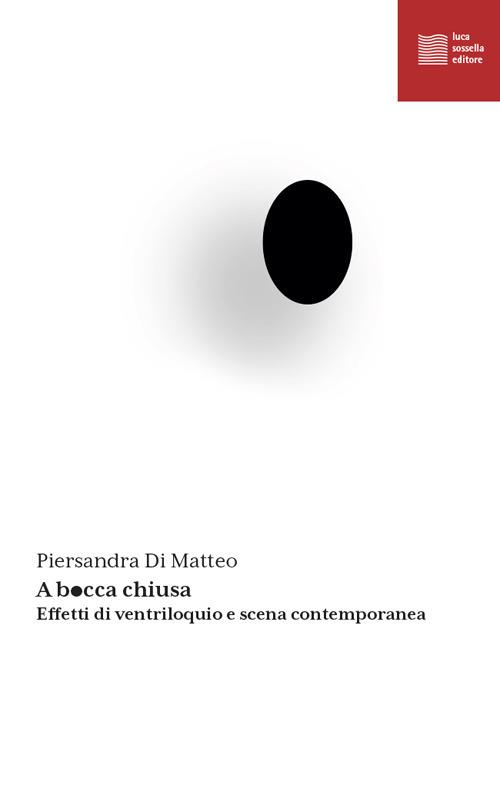Pubblichiamo un saggio di Filippo La Porta dall’ultimo numero di Parole-Chiave. Classi (Carocci), ringraziamo l’editore per la disponibilità
«Sessant’anni di pace, e viverli tutti, sono una bella botta di culo. Ma quella che chiamiamo pace non fu altro che una forma terrificante di guerra intestina… la feroce & sanguinosa guerra tra le classi, ma non solo… sono stati sessant’anni di guerra tutti contro tutti, che dura ancora, quella degli interessi individuali per l’accaparramento di potere e risorse, per la conquista di posizioni dominanti» (Francesco Pecoraro, Questa e altre preistorie, Le Lettere, 2008). Pecoraro quindici anni fa pubblica in un libro i suoi interventi in Rete firmati come Tashtego e racconta la catastrofe epocale e quotidiana del nostro tempo. Quella che doveva essere la fine della preistoria, prevista da Marx come conseguenza di una dialettica della Storia virtuosa (certo non inevitabile ma ragionevolmente possibile), somiglia a un’epoca che sembra regredire all’età della pietra.
Ma che fine ha fatto il “popolo” di una volta? Quello di Vasco Pratolini – un popolo stratificato che pure proveniva dall’Ottocento e che è stato variamente interpretato in politica – non esiste più. È stato sostituito dalla massa, per sua natura indifferenziata, e anzi, come ci avverte Asor Rosa, dalla «massa mediocre che ha stabilito con il sistema democratico un compromesso, che consiste nell’accettare di viverci dentro, svuotandolo» (si veda Scrittori e massa, 2014, pubblicato cinquant’anni dopo Scrittori e popolo, 1965). Si tratta della massa apatica, passiva, del tutto acritica delle democrazie attuali, non di quella in perenne sovreccitazione dei fascismi. Mario Tronti aggiunge che coincide con il borghese-massa (una locuzione che ricalca quella celebre dell’operaio-massa, privo di professionalità, protagonista del ciclo di lotte sociali degli anni Sessanta e Settanta), con l’uomo-massa democratico “sbarcato sul nostro continente insieme agli eserciti degli Alleati”, che per lo stesso Tronti si è tradotto in un “totalitarismo democratico”, con la fine della politica e del pensiero stesso. Concordo con la diagnosi ma ho qualche dubbio sulle conclusioni – certo comprensibili ma per me unilateralmente apocalittiche – di quelli che furono i padri dell’operaismo teorico, come dirò tra poco.
Vorrei anche precisare che questa ricognizione sul tema delle classi sociali nella letteratura italiana contemporanea è tutt’altro che esaustiva. Non basterebbe un intero saggio. Per comodità distinguo subito due temi distinti, che pure hanno attinenza con la questione delle classi sociali: la rappresentazione letteraria del lavoro, del lavoro post-fordista fondato su intelligenza, informazione, socialità, attitudine dialogica (insomma il capitalismo cognitivo della celebre pagina dei Grundrisse sul “general intellect”); e poi la rappresentazione letteraria del denaro. Cominciamo da qui.
La roba
“Il denaro. I soldi. La pilla. I baiocc. Gli sghei. I ghell. I danee. La grana…”. Nel romanzo di Simona Vinci, Stanza 411 (Einaudi, 2006), crudo resoconto di una claustrofobica, febbricitante passione amorosa – raccontata dentro una stanza d’albergo a Roma –, ci si imbatte in una pagina sul denaro. Mentre nel Ritorno a casa di Enrico Metz di Claudio Piersanti (Feltrinelli, 2006) al protagonista, un potente legale ora solo consulente e deciso a ritrovare la propria vita, viene affidata una valigetta piena di banconote di grosso taglio, da consegnare poi ad altri. Così il silenzioso Convitato di pietra, ai margini della attuale “rappresentazione” pubblica – cioè il denaro, la ricchezza personale – rientrava prepotentemente in letteratura, dopo un lungo periodo di imbarazzata rimozione. Ma proprio un tema del genere dimostra quanto sia cambiata la realtà negli ultimi due secoli, e il modo di rappresentarla. Il denaro, protagonista e motore di trame nel romanzo ottocentesco, da Balzac a Dickens, da Gogol a Verga, appare via via più defilato nella narrativa del Novecento, entro un mondo che sembra smaterializzarsi. Limitandoci al nostro paese, l’ultima volta in cui incontriamo il denaro come oggetto fisico, era stato alla fine degli anni Ottanta, con la valigetta (un’altra!) che padre e figlio portano in Svizzera in Per dove parte questo treno allegro, opera prima quasi ricalcata sul Sorpasso di Risi, di Sandro Veronesi, e nelle esotiche banconote false de I fannulloni di Marco Lodoli, autore che riuscì a incantare Fellini.
Da allora i romanzi che raccontano la razza padrona (Edoardo Nesi, Tullio Avoledo, Sebastiano Nata…) non ci parlano direttamente del denaro, peraltro quasi sparito dalle nostre esistenze. E inoltre si astengono da giudizi morali diretti. Spostandoci invece di una generazione, gli scrittori italiani che hanno vissuto la modernizzazione convulsa degli anni Sessanta si presentavano quasi tutti come severi censori dei nuovi stili di vita, e dell’ideologia che li ispira: Goffredo Parise indicava come fine di ogni vera educazione il semplice fatto di amare il mondo più delle cose; mentre Elsa Morante osservò una volta che la Roll’s Royce è spazzatura, e anzi merda, e che possederla o desiderarla è esattamente lo stesso…
Affermazioni di inguaribili esteti, di letterati snob che condannano i volgari consumi ben al riparo dei loro privilegi materiali? Certo è singolare che il “problema” venga posto in modo così radicale da alcuni scrittori e non dai leader politici della sinistra di quegli anni (eccettuata la poco convinta “austerità” berlingueriana). Ed è ancor più singolare che una scrittrice come Simona Vinci, immersa in una contemporaneità sempre più convinta della corrispondenza tra denaro e merito, riproponga attraverso un suo personaggio l’idiosincrasia morale per i soldi (e per il potere che implicano): «Ancora una volta il tema dei soldi entrava nella mia vita e mi riempiva di schifo…». Ricordo anche un filone filosofico-antropologico recente, da Ivan Illich a Serge Latouche (e più indietro Thoreau), che insiste sulla rinuncia non penitenziale ma gioiosa al lusso e su una abbondanza frugale. Ma cosa può insegnarci la letteratura? Non ci chiede di convertirci a un’etica pauperistica, né deve dispensare scomuniche sociali. Piuttosto ci mostra alcuni destini concreti e i probabili effetti di alcune scelte.
Sebastiano Vassalli decide di trattare frontalmente la centralità dei soldi in Comprare il sole (Einaudi, 2012), scegliendo la forma della favola. E come ogni vero romanziere si mette a indagare “scientificamente” cause e effetti della eterna commedia umana. Quando la giovane Nadia Motta vince al super-lotto 21 milioni di euro, siamo subito curiosi di vedere in che modo la sua esistenza ne verrà destabilizzata. Vassalli rappresenta la natura sfuggente, metafisica di una cosa pure così materiale come i soldi: luccicanti e odorosi nel deposito dove si tuffa Paperon de’Paperoni, ma anche ridotti ad astrazioni, a numeri che transitano misteriosamente nei conti correnti delle Società, aprendo e tappando buchi. Alla fine quelli di Nadia si perderanno nel nulla.
Infine Walter Siti, uno degli scrittori italiani più interessanti degli ultimi decenni. Qualche volta la sua narrativa sembra identificarsi etologicamente con l’aggressore, e così è impregnata di un realismo un po’ cinico e a tratti decadente. Però in Resistere non serve a niente, vincitore del Premio Strega nel 2013, attraverso il ritratto di Tommaso – vizioso e candido, borgataro divenuto artista della finanza – si enuclea una ovvia ma preziosa verità morale che andrebbe fatta circolare, anche perché i deprecati “mercati”, causa di tutti i mali, siamo anche noi, con le nostre aspettative, ingordigie, percezioni distorte, e non riguardano solo mafiosi e criminali. Una verità che “tradisce” la formazione umanistica dell’autore: il denaro comanda e può comprare tutto, tranne una relazione, al massimo può comprare la finzione di una relazione.
Letteratura post-industriale
Lo scrittore Tullio Avoledo, autore dell’Elenco telefonico di Atlantide (Sironi, 2002), ha dichiarato in un incontro pubblico: «Mio nonno faceva il contadino, mio padre il falegname, io non so, letteralmente, che lavoro faccio, cosa produco!». E così accade nel suo romanzo, in buona parte autobiografico, dove il consulente giuridico di una piccola banca si trascina di riunione in riunione, sempre sul punto di essere trasferito o di essere considerato “in esubero”, sullo sfondo di complotti esoterici. Dunque, al centro della nostra società, o almeno della nostra vita professionale, proprio come al centro della Terra per Giulio Verne, troviamo un vuoto, uno spazio cavo e insondabile… Un vuoto che poi si riflette minacciosamente su tutta l’esistenza, sui nostri affetti, sui nostri comportamenti. In realtà il lavoro continua a sostenere l’economia, soltanto che ha cambiato radicalmente volto, diventando irriconoscibile, non ben identificabile. Sappiamo che si è esaurita la “civiltà” industriale: nelle aree dismesse occidentali, in quei grandi capannoni che ospitavano macchinari, fioriscono centri sociali, università e discoteche. La fabbrica si è frammentata e decentrata su tutto il globo. Poiché i mercati sono quasi saturi di beni al lavoro materiale si sostituisce quello immateriale, dove infatti la principale forza produttiva diventa l’informazione, e, come si dice nel romanzo “terminale” di Giuseppe Montesano Di questa vita menzognera (Feltrinelli, 2005), non si vendono più le cose ma idee e stili di vita; dove alla dipendenza dalla macchina si sostituisce la dipendenza ancora più insidiosa da altre persone (la centralità delle “relazioni interpersonali”, appunto delle interminabili riunioni e dei breefing, di cui occorre conoscere trucchi e regole), dove al posto fisso subentrano lavori a termine, collaborazioni, consulenze… Come apprendiamo da uno dei racconti di Oliviero La Stella – Lo sdraiatore (Fazi, 2002) –, il requisito principale non è più la professionalità ma la “disponibilità”. E tutto questo ha conseguenze sulla personalità stessa, che deve diventare flessibile, adattabile, e perfino programmaticamente “sleale”, pronta cioè a cambiare con disinvoltura datore di lavoro, come avverte il sociologo Richard Sennett (nel fondamentale L’uomo flessibile, Feltrinelli, 2000), con conseguenze socialmente distruttive, o almeno schizofreniche: negli Stati Uniti oggi un padre giudizioso continua ad educare i figli secondo valori di dedizione, coerenza, fedeltà (alla famiglia, a un amico, all’azienda) che lui stesso però deve negare ogni giorno per avere successo! Prevale su tutto quanto l’irrealtà del nuovo mondo del lavoro, fatto di cose molto astratte come schermi luminosi, monitoraggi di situazioni, fiumi di parole, abilità nel persuadere o nella “gestione” dell’apparenza… Una irrealtà più o meno morbida o confortevole, di cui la nostra narrativa riesce a rendere conto solo in parte.
Per molti anni i nostri romanzi parlavano soltanto – in modo autoreferenziale – di giornalisti, redattori di case editrici, traduttori, scrittori, insegnanti ecc., insomma i mestieri di chi quei romanzi li scriveva (il “lavoro culturale” che intitolava un libro di Bianciardi). Poi l’orizzonte sociologico si è ampliato e abbiamo cominciato a vedere imprenditori di provincia (Edoardo Nesi), pony-express (Gianpaolo Spinato), ragazze di chat line porno (Francesca Mazzucato), sottoccupati eternamente precari (Giuseppe Culicchia), licenziati forzosamente contenti (Massimo Lolli), magazzinieri (Paolo Nori), postini (Angelo Ferracuti), una moltitudine di extracomunitari più pittoreschi che verosimili… Dopo la letteratura industriale di mezzo secolo fa auspicata negli anni del boom da Vittorini, e poi incarnata in alcune opere esemplari di Parise, Ottieri, Volponi, Mastronardi, Bianciardi ecc., albeggia una letteratura post-industriale.
D’altra parte c’è ancora oggi la persistenza della vecchia fabbrica e della sua ferrigna “materialità”: i romanzi quasi chapliniani di Antonio Pennacchi, gli operai di Paolo Nelli, l’“apprendista” votato a una filosofia della fabbrica quasi “toyotista” del bel racconto omonimo con cui esordì Giulio Mozzi. In questi libri la fabbrica appare come alienazione ma anche come immagine – ribaltata – di un’utopia sociale, fatta di cooperazione, socialità, orgoglio lavorativo, coscienza dei produttori. E siccome il Progresso è fatto sempre di due passi avanti e uno indietro, nelle patrie lettere trovano spazio anche i mille lavori semisommersi dell’Italia rurale, un po’ folle e un po’ fiabesca, di Vincenzo Pardini e Guido Conti, con la loro straziata epica – rispettivamente – della Lucchesia e della Padania. Ma è leggendo le pagine del Dipendente di Sebastiano Nata (Feltrinelli, 1995) che abbiamo avuto la percezione di un mutamento epocale, con quel top manager che per vendere carte di credito deve possedere soprattutto doti da imbonitore: «Bisogna guardare negli occhi di chi ti ascolta. Metterlo sotto ipnosi… serve a un tubo il master». E una ingegnosa arte di arrangiarsi ispirava pure i personaggi del notevole La ballata degli invisibili di Marilia Mazzeo (Frassinelli, 1999), tutti precari alla ricerca di un impossibile lavoro fisso e con molte, fumose velleità artistiche.
Ma sul precariato vorrei almeno segnalare anche Cordiali saluti di Andrea Bajani (Einaudi, 2005), Mi chiamo Roberta, ho 40 anni, guadagno 250 euro al mese di Aldo Nove (Einaudi, 2006), Il mondo deve sapere. Romanzo tragicomico di una telefonista precaria di Michela Murgia (2010, poi Einaudi, 2016). Spostiamoci al pubblico impiego. Nel racconto Spettabile Ministero, compreso nella raccolta La manutenzione degli affetti di Antonio Pascale (Einaudi, 2003), l’impiegato neoassunto che confessa al dirigente di non averci capito niente in un documento ministeriale si sente rispondere “Allora è perfetto”. Il potere, come abbiamo visto, deve mostrarsi esoterico oltre che imbonitore. Un’umanità più agile, illimitatamente disponibile, opportunistica e un po’ anguillesca, pronta a reinventarsi, a riadattarsi sempre. Un’umanità che non c’è, corrispettivo del lavoro che non c’è… Ci dovrebbe spaventare? Tutt’altro. A ben vedere siamo interamente dentro il nostro (deprecato) carattere nazionale. Italiani ancora uno sforzo: chissà che l’universo della New Economy non rappresenti la nostra grande occasione!
Letteratura working class
Certo la classe operaia non si è dissolta del tutto, anche se non si raccoglie più nelle grandi concentrazioni degli anni Cinquanta e Sessanta. Esiste una letteratura working class che continua a raccontarci la vita degli operai, specie fuori della fabbrica, come ci ha mostrato Alberto Prunetti, che ha vissuto per lungo tempo in Inghilterra (cita Ken Loach), autore dei romanzi Amianto. Una storia operaia (Alegre) dedicato al padre, 108 metri e Nel girone dei bestemmiatori (entrambi Laterza). Poi Prunetti ha scritto il fondamentale saggio Non è un pranzo di gala. Indagine sulla letteratura working class (minimum fax, 2022), intendendo per working class non solo gli operai di fabbrica e il lavoro salariato ma l’universo dei precari, sottoccupati, atomizzati, poveri, non protetti: il soggetto sociale protagonista del movimento del ’77, quell’“operaio sociale” che poi Toni Negri e Michael Hardt hanno travasato nella “moltitudine” spinoziana, rete di singolarità irriducibili e nuovo soggetto rivoluzionario (dove la suggestione teorica prevale largamente su una analisi sociologica puntuale). Forse l’autore avrebbe dovuto dare più spazio alla letteratura migrante o italofona (scritta in italiano dagli immigrati), nata intorno al 1990 e che comprende circa 500 autori: in questa letteratura il lavoro precario è uno dei temi ricorrenti.
Prunetti, che ha fatto i mille mestieri, viene – orgogliosamente – dal basso. Non frequenta il coté borghese della maggior parte dei nostri scrittori, quando si presenta alle case editrici lo prendono per il tecnico delle caldaie! Nei suoi libri intende documentare una realtà lavorativa semisommersa, invisibile, che caratterizza oggi l’economia dei paesi occidentali e che ha sperimentato di persona.
Neoproletariato
Abbiamo citato l’opera di esordio di Pecoraro. Nei libri successivi – La vita in tempo di pace (Ponte alle Grazie, 2013) e Lo stradone (Ponte alle Grazie, 2019) –, potenti romanzi-saggio in cui la forma stessa riproduce caos e frammentazione pur nella ricerca di un ordine, l’autore continua tra l’altro la sua disincantata ricognizione sulla società italiana. Nello Stradone descrive un ceto che abita la Terra di Mezzo tra pochissimi privilegiati di fatto invisibili e la massa indistinta di disperati che rovistano nei cassonetti (in una pagina sulla storia del quartiere, Valle Aurelia, vi si parla della ciminiera del “Monte d’Argilla”, che per secoli ha rifornito di mattoni, e in definitiva costruito, la capitale). Potremmo dire una classe medio-bassa che Tommaso Labranca – qui citato – definiva più o meno propriamente “neoproletariato”, il quale «sogna tre cose che cominciano per F: fitness, fashion, fiction». Nel suo Neoproletariato. La sconfitta del popolo e il trionfo dell’eleghanzia (Castelvecchi, 2002), Labranca sostiene che questa nuova classe, questo popolo del discount e delle televendite, che vive di lavori a provvigione (tra New Economy e agenti immobiliari) aspira non al plusvalore ma al plus-cool, ossia al superfluo, a una pseudo-eleganza entro una estetizzazione della vita quotidiana.
L’autore a un certo punto scrive beffardamente: «Neoproletari di tutto il mondo separatevi, individualizzatevi, opprimete il vostro simile con la vostra carica di eleghanzia superiore». A volte il neoproletariato labranchiano sembra stingere nel Lumpen, altre volte corrisponde solo a una sensibilità diffusa e interclassista, a un “luogo dell’anima”, ma l’intuizione sociologica resta notevole.
“Massa” vs democrazia?
Ora, questa umanità post-moderna, post-morale, post-tutto, attraversa le classi e le ideologie, non ha più una precisa rappresentanza politica e abita un mondo illimitatamente fluido. Il punto, però, è che la pre- sunta scomparsa delle classi non significa scomparsa delle disuguaglianze socio-economiche, le quali anzi si sono allargate. Si potrebbe dire pasolinianamente: oggi l’immaginario è omologato, Montezemolo e l’ultimo dipendente della fiat aspirano agli stessi consumi, solo che il primo può acquisirli, il secondo non sempre. Ma torniamo alle conclusioni di Asor Rosa e Tronti. Certo le classi di una volta non ci sono più, con la propria fisionomia e cultura specifica, ma siamo sicuri che la “massa” sia solo quella realtà magmatica, mostruosa, “blobbiana” che viene illustrata con accenti apocalittici?
La massa è composta da individui, mai del tutto massificati: proprio nel capitalismo cognitivo dove ciascuno può sviluppare potenzialmente la propria funzione intellettuale, la contraddizione non è più tra élite e volgo, tra intellettuali e popolo, ma passa dentro ogni persona: dentro ciascuno di noi abitano un uomo-massa conformista e apatico e un individuo consapevole, responsabile, con autonomia e capacità critica. Non sarà che questo borghese-massa ci preoccupa tanto perché – ispirato dal mantra ossessivo “uno vale uno” – non ascolta più le élite, non riconosce alcuna autorevolezza ad una casta intellettuale se- parata o a figure un pò obsolete di maître-à-penser, non intende farsi egemonizzare?
Viene dall’America, certo, ed è la ragione per cui l’America ha vinto nel secolo breve sui totalitarismi: la gente preferisce alla eccitazione delle adunate, alla mobilitazione permanente, ai sacrifici collettivi, alle grandi imprese eroiche della nazione, una vita quotidiana piuttosto regolare e confortevole, con il frigo e la lavatrice, con la televisione e il condizionatore. Probabilmente una democrazia ha bisogno di cittadini attivi e informati, con la voglia di deliberare ecc., mentre il borghese-massa di Tronti è privo di senso critico e di slanci ideali, disinteressato alla politica.
Insomma: Tocqueville non aveva previsto Hollywood. La cultura di massa, generando una massa eterodiretta, minaccia dall’interno la democrazia. Però la cultura di massa è a sua volta variegata e fortemente disomogenea: in una memorabile puntata dei Simpson, dove Bart si vende l’anima, c’è una intelligente rilettura della tradizione umanistica. E poi: perché definire “mediocre” qualcuno che vuole vivere onestamente entro una dimensione privata, “nella prossimità” diceva Nietzsche, a contatto con gli affetti più cari e con i piccoli piaceri quotidiani, frequentando il vicinato, senza grandi ambizioni, senza il desiderio di partecipare a qualche comitato, e con l’innocente “capriccio” di potersi acquistare l’ultimo modello di iPhone o di televisore al plasma per vedersi meglio le partite di calcio o le serie su Netflix? Per caso coincide con un tipo umano inferiore e arretrato, con un “bruto” (secondo l’orazione dell’Ulisse dantesco) addirittura privo di pensiero?
La politica ridefinita
Provo sempre più simpatia per gli oziosi Oblomov dispersi nella folla, per le apatiche signore dei romanzi di Jane Austen che passano la vita su un sofà, per chi non smania di partecipare (“libertà è partecipazione”, ci ha svelato Gaber, l’hanno messa lì nella canzone solo perché suonava bene!), e meno che mai di riparare il mondo. Inoltre: nella attuale guerra di tutti contro tutti – quasi un ferino stato di natura hobbesiano – si insinuano pur sempre forme di cooperazione e collaborazione, di rivolta e di rifiuto, di resistenza e di sperimentazione sociale. Il conflitto, lungi dallo sparire (dalla Primavera Araba del 2011 che ha usato i social, al populismo turbolento dei Gilet gialli francesi nel 2018), viene rimodulato in forme nuove, spesso spiazzanti, che abbiamo il compito di decifrare anche con l’ausilio dell’immaginazione sociologica dei nostri romanzieri.
Oggi accanto allo svuotamento della democrazia e al ridimensionamento della politica assistiamo a una cultura diffusa di pratiche di cittadinanza attiva, reti di contropoteri, esperienze assembleari di base. Una politica ridefinita: non più tecnica per conquistare il potere ma dimensione microcomunitaria e autoeducativa. La fine delle classi coincide con la fine dei partiti (che le rappresentavano) e delle compatte, monolitiche appartenenze collettive. Potrebbe essere una buona notizia. Oggi al centro della scena c’è di nuovo l’individuo, che non è la monade borghese, egoista e sigillata in se stessa, ma l’individuo ribelle e responsabile della tradizione anarchica non-violenta che dice no al potere (l’“uomo in rivolta” di Albert Camus), e che può contare sulla amplificazione della Rete (anche in Hegel la dialettica nasce storicamente con il dire no del contadino medievale). Anche perché, ammoniva Nicola Chiaromonte, dalla caverna si esce uno alla volta, non in gruppi.
Certo la pace dell’Occidente è precaria, turbata dalla pulsione individuale – non più “educata” dalla politica – ad accaparrarsi potere e risorse. Contiene, secondo Pecoraro, un presagio di catastrofe. Darwin oggi ci soccorre più di Marx. Eppure il fatto che alle identità collettive di classe, con le fumose narrazioni e spettacolari mitologie politiche che l’hanno accompagnate, si è sostituita la figura di un individuo smarrito sì nella liquidità ma in molti casi indocile, nomade, creativo, e “naturalmente” cooperante, potrebbe rimettere in moto la cigolante dialettica della Storia. Un individuo sempre dentro la relazione con gli altri, però capace – secondo l’auspicio di Hannah Arendt – di cominciare qualcosa di nuovo (nella sfera pubblica) insomma di ridurre nella propria esistenza la parte del “lavoro” (comunque determinato dalla necessità) e di ampliare la parte dell’ “agire”, vertiginosamente aperto alla libertà.