Gli automi parlanti portano una sfida radicale alle nostre concezioni di linguaggio, cultura e umanità. E invitano a esplorare con rigore e sensibilità un mondo in cui le frontiere tra umano e artificiale si ridefiniscono, interrogando la nostra capacità di convivere con queste nuove presenze, Intelligenze aliene. Linguaggio e vita degli automi (Luca Sossella editore) di Guido Vetere verrà presentato martedì 25 febbraio alle ore 18:30 con l’autore insieme aMaurizio Lenzerini, Mario De Caro e Luca de Biase presso la libreria Spazio Sette di Roma.
Con la comparsa degli automi parlanti, come ad esempio i chatbot, ultima frontiera dell’intelligenza artificiale, l’umanità non si confronta solo con una nuova tecnologia, ma è chiamata a riflettere sul proprio rapporto con il linguaggio, fulcro della vita psichica e sociale. Specialmente nel XX secolo, la filosofia ha guardato al linguaggio come la materia costitutiva della coscienza e il fondamento delle relazioni umane. Cosa accade oggi quando anche gli automi si mettono a parlare?
L’opera inizia richiamando lo spettro inquietante evocato dall’Invasione degli ultracorpi di Don Siegel (1956): alieni che imitano perfettamente l’essere umano, privandolo tuttavia della sua personalità. Così, le macchine moderne replicano perfettamente il linguaggio ma allo stesso tempo ne restano separate, incapaci di comprenderne il nucleo simbolico e intenzionale. Si profila la presenza immanente di un’intelligenza aliena, che ci interroga non tanto sulla sua natura tecnologica, quanto sul modo in cui essa potrebbe trasformare la nostra vita linguistica e con essa la nostra vita sociale.
La riflessione prende avvio dalla “svolta linguistica” della filosofia novecentesca per riconnettere alcuni suoi temi alla tecnicalità dei modelli generativi dell’intelligenza artificiale attuale. Sia nella filosofia, sia nella tecnologia, l’ambizione razionalista della logica formale si confronta con l’empiria pragmatica dei modelli quantitativi e statistici. Nel linguaggio dell’intelligenza artificiale la parola non è un segno, ma una probabilità, una previsione, un moto dell’automa nel campo di forze indotto dalla testualità. L’algoritmo che sceglie la prossima parola nella frase che va generando è un compositore di melodie linguistiche assonanti ma prive di intenzioni significative.
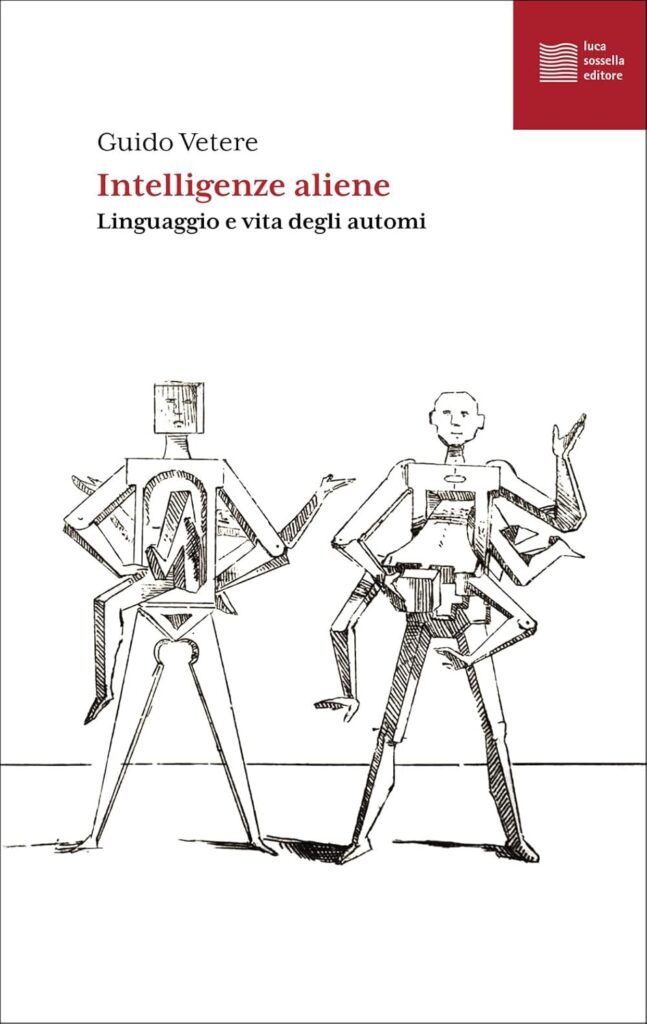
L’analisi dell’autore non si limita alla scienza e alla tecnica; il libro prende posizione rispetto a un dibattito sociale e culturale di grande attualità. L’irruzione degli automi parlanti e la loro crescente integrazione nella vita quotidiana sollevano urgenti domande sull’etica, sulla libertà e sulla responsabilità. Come possiamo convivere con questi oggetti-soggetti che sembrano tanto umani pur nel loro automatismo, che ci inquietano ma si dimostrano utilissimi in molti compiti finora esclusivo appannaggio del lavoro cognitivo? La risposta non risiede nel silicio delle imperscrutabili reti neurali, ma nelle “forme di vita” che sapremo costruire mobilitando la nostra coscienza critica.
Da questa posizione viene il rifiuto di una visione essenzialista e soluzionista che mette il problema del rapporto con l’artificiale a carico degli algoritmi e della tecnologia, ritenendo ad esempio di poter certificare l’etica gli automi parlanti con le procedure di collaudo simili a quelle dell’ingegneria del software. Viene anche il rifiuto della falsa dicotomia apocalittici–integrati che già Umberto Eco aveva criticato negli anni ’60. Le immagini distopiche di un’umanità soggiogata dagli automi e quelle utopiche di una intelligenza artificiale generale in grado di rispondere alla “domanda fondamentale della vita, dell’universo e di tutto quanto” sono entrambe da respingere. In realtà, l’ecosistema dell’intelligenza artificiale generativa è molto più articolato e complesso di quanto emerge da certe (non neutrali) cronache, essendo animato da migliaia di gruppi di ricerca, pubblici e privati, impegnati a produrre tecnologie e risorse anche nello spirito dei sistemi aperti e trasparenti. Orientare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale verso l’innovazione sociale, anziché verso il profitto, è una possibilità concreta. Realizzarla richiede tuttavia l’impegno attivo dell’intelligenza umana, basato su una chiara e ampia visione di ciò che sta accadendo e che potrà accadere.
In questa esplorazione critica, il libro non è solo un viaggio nella storia delle idee e delle tecnologie, ma una riflessione sul destino umano in un mondo condiviso con nuove forme di intelligenza. Che siano – come si dice – minaccia o opportunità, gli automi parlanti ci obbligano a un confronto profondo con noi stessi, con il nostro linguaggio, e con la nostra capacità di attribuire significato al mondo.