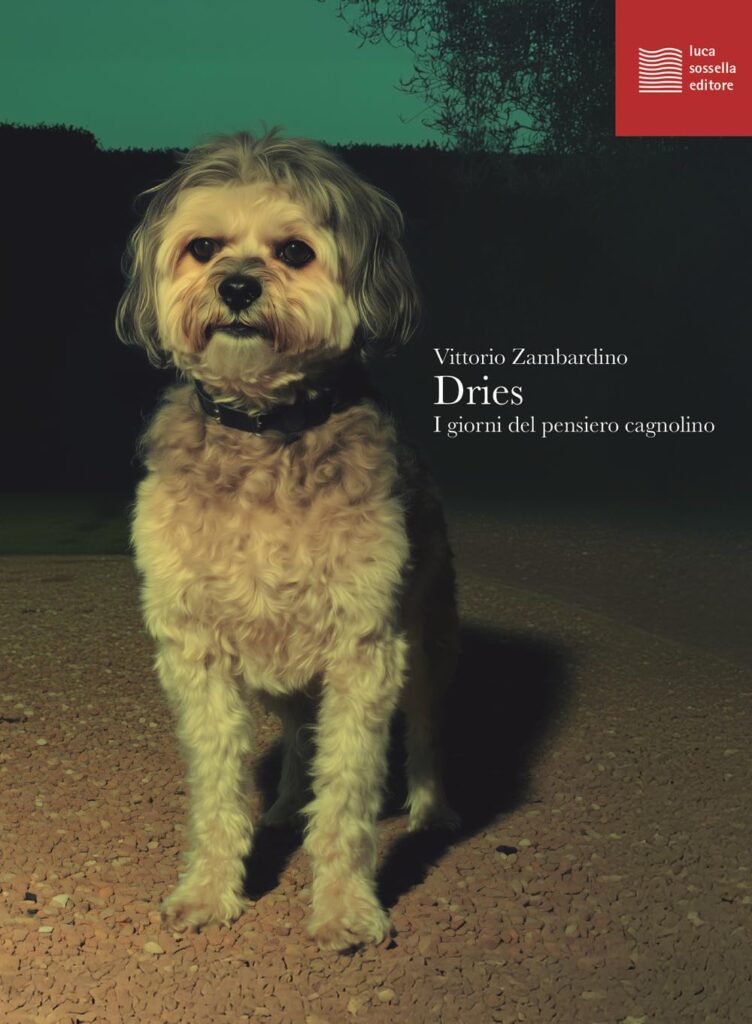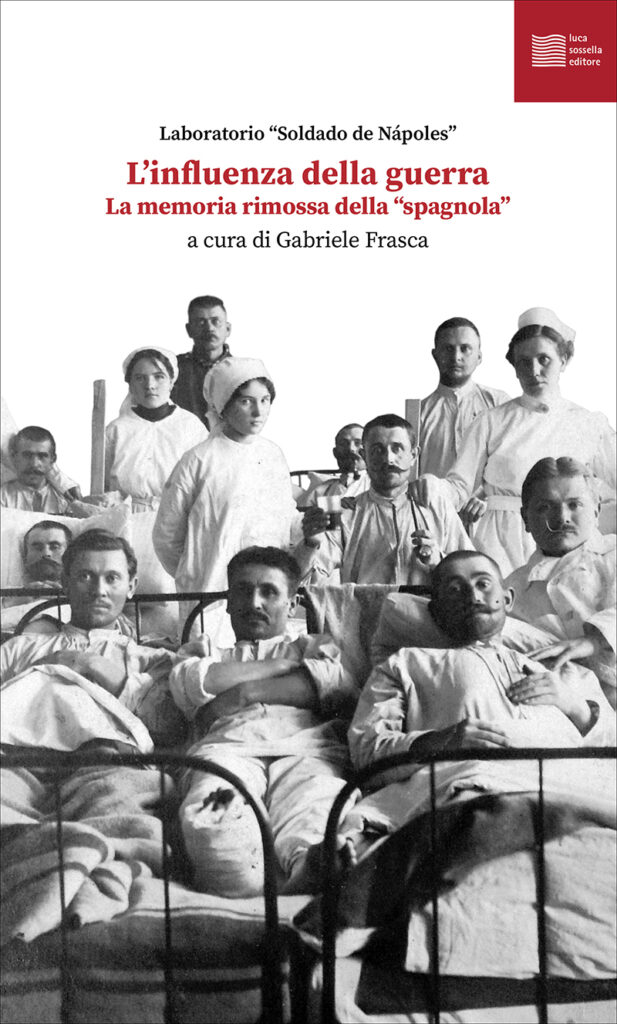La performance, le arti performative e i performance studies sono concetti, relativamente recenti e non del tutto definiti, che abbracciano varie pratiche artistiche e teoriche. Tralasciando le molteplici definizioni linguistiche e semantiche, con il termine “performance” intendiamo un comportamento, un’esibizione, un evento o un’azione pubblica. Con “arti performative” intendiamo, invece, le diverse pratiche artistiche, i modi del fare, come la performance art, la body art, gli happening, le diverse scritture coreografiche e corporee, che non sono solo oggetto di studio della storia dell’arte e dello spettacolo, ma anche dei performance studies. Con cui proponiamo una disciplina, nata come sintesi di diverse discipline scientifiche: l’antropologia, la teatrologia, la sociologia, l’estetica, la filosofia, la psicoanalisi teorica, e i cultural, feminist, gender e queer studies ecc. A prima vista, una gamma così vasta di discipline e di metodi può sembrare incoerente, ma dimostra la “democraticità” e l’apertura dei performance studies, che permettono la ricerca e l’analisi di tutti gli aspetti del comportamento umano e postumano, dalle più semplici performance nella vita quotidiana fino alle diverse performance artistiche e culturali, incluse la performatività della scienza e della natura.
Fin dalla loro fondazione, i performance studies non si limitano all’analisi degli atti performativi ma anche all’analisi dei loro contesti sociali, politici e culturali, così come le conseguenze che ne derivano. Sono proprio i contesti e le conseguenze ciò che la nostra ricerca si propone di articolare. Grazie ai performance studies, la nostra conoscenza di ciò che è definito come “performance” è continuamente indagata in quanto esempio di una vitale prassi artistica e allo stesso tempo come uno strumento per interpretare i molteplici processi sociali, politici, culturali. Precisamente, questo volume rappresenta un tentativo di rivolgere l’attenzione ai complessi mutamenti sociali e culturali del nostro tempo, influenzati dalle tecnologie, dalla mediatizzazione della società, dal discorso radicalizzato della coscienza civile, dai problemi ecologici, dai nuovi discorsi bioetici, dalla medicalizzazione e dalla mediatizzazione del corpo, come anche dalla globalizzazione e dal nuovo ordine del mercato neoliberale.
I performance studies si sono sviluppati e ramificati in molteplici direzioni e di recente hanno subito notevoli cambiamenti, che a livello epistemologico riflettono le tendenze di fondo e le tensioni interne alle discipline umanistiche, dalla storia dell’arte e spettacolo ai cultural studies. La complessità e diversità dei performance studies è spesso utilizzata per leggere e interpretare diversi fenomeni, eventi, concetti e testi sociali e culturali. Negli ultimi due decenni l’apertura degli studi verso il nuovo materialismo, le grammatiche dell’espressione corporea, le pratiche discorsive, la performatività della natura, il postumano e le diverse forme di femminismo (femminismo intersezionale, anarco-femminismo, eco-femminismo ecc.) ha permesso di sviluppare nuovi approcci e metodologie interdisciplinari. Il nostro lavoro rappresenta, quindi, un tentativo di offrire diverse definizioni, gettando al contempo uno sguardo critico sull’istituzionalizzazione dei performance studies, spesso definiti come una postdisciplina. Tale definizione implica che si tratti di un nuovo metodo che supera la precedente suddivisione delle discipline accademiche e che è in continua evoluzione, soggetto al cambiamento tanto quanto la società circostante.
Ci proponiamo che la ricerca così concepita possa costituire una guida per tutte le persone interessate allo sviluppo dei performance studies, così come delle discipline affini, quali gli studi postfemministi e postcoloniali, queer, black ed indigenous studies, le teorie di decolonizzazione e deculturalizzazione, così come anche le nuove forme dell’estetica e della filosofia delle arti.
La performance, come categoria generale, deve essere costruita come ‘vasta gamma’ oppure ‘continuum’ di azioni a partire da rituale, gioco, sport, divertimento popolare, arti performative (teatro, danza, musica) e performance quotidiane, fino all’esecuzione dei ruoli sociali, professionali, di genere, razza e classe, alle pratiche curative (da sciamanesimo a chirurgia) e alle varie rappresentazioni e costruzioni di azioni nei media e su internet.
R. Schechner, Foreword: Fundamentals of Performance studies, in Teaching Performance studies
Secondo questa definizione di Schechner, molte performance appartengono a più di una categoria (per esempio i giochi olimpici sono contemporaneamente una manifestazione sportiva, ma anche un grande rituale sociale e un evento mediatico). Lungo il continuum delle pratiche performative si sommano costantemente nuove forme, mentre altre vengono eliminate. Inoltre, a differenza della teatrologia, della filmologia, o della storia dell’arte, i performance studies non sono legati a un medium preciso. Questo rende i performance studies particolarmente adatti per analizzare tutte le possibili forme di espressione artistica e altri tipi di espressione che sintetizzano e integrano movimento, suono, linguaggio, narrazione, corpi e oggetti. Come già notato, l’accento va posto soprattutto sul comportamento, il suo contesto e la sua percezione. Un’opera d’arte può essere la stessa, sia che venga esposta in un museo o in una galleria, ma inserita in un diverso contesto di esposizione e percezione, essa acquisisce nuove connotazioni, anche nel caso in cui si tratti dello stesso artefatto. In altre parole, la particolarità dell’opera non sta nella sua materialità, ma nella sua interattività, anche se si tratta di oggetti materiali. Di conseguenza, i performance studies non sono semplicemente una teoria sulle arti performative, ma una forma di percezione che permette di individuare diverse forme di esperienza. Queste esperienze possono incrinare o rovesciare il regime epistemico esistente, creando nuove grammatiche della performance, avvicinando i performance studies al pensiero di Jacques Rancière, che definisce l’estetica come una nuova partizione del sensibile.
Chiamo partizione (partage) del sensibile quel sistema di evidenze sensibili che rendono contemporaneamente visibile l’esistenza di qualcosa di comune e le divisioni che, su tale comune, definiscono dei posti e delle rispettive parti. Una partizione del sensibile fissa, dunque, allo stesso tempo un comune condiviso e delle parti esclusive. Questa partizione delle parti e dei posti si fonda su una ripartizione (partage) degli spazi, dei tempi e delle forme di attività che determina il modo stesso in cui un comune si presta alla partecipazione e il modo in cui gli uni o gli altri avranno parte a questa partizione.
J. Rancière, La partizione del sensibile: Estetica e politica, DeriveApprodi, Roma 2022.
I performance studies trattano la performance secondo quattro direttrici principali.
In primo luogo, considerano qualsiasi comportamento umano “ripetuto” o “preparato” come un oggetto di ricerca, prestando particolare attenzione a quelli che rivelano l’artificialità sociale nascosta dietro la cosiddetta “naturalezza” della vita quotidiana. Sebbene i teorici della performance facciano ampio ricorso a materiali d’archivio (libri, articoli, saggi, fotografie, documenti archeologici ecc.), la loro attenzione principale si concentra su ciò che Diana Taylor definisce come “repertorio incarnato”, ovvero un insieme di pratiche, gesti e memorie che si trasmettono attraverso il corpo, costituendo resti vivi del processo performativo.
In secondo luogo, un aspetto cruciale dei performance studies è rappresentato dalla performance art. Numerosi teorici e artisti che si occupano di forme di performance considerate nuove, sperimentali e d’avanguardia hanno già integrato direttamente molte delle tecniche e delle forme della performance art. Questo ha reso quasi integrale il rapporto tra la realizzazione della performance, la sua interpretazione critica e lo studio teorico.
La terza direttrice dei Performance Studies è il metodo antropologico della “descrizione densa” (thick description) elaborato da Clifford Geertz (The Interpretation of Cultures, 1973), che nei performance studies assume una nuova configurazione nell’analisi e nell’osservazione della performance. Se in antropologia la descrizione densa era impiegata per comprendere culture “altre”, nei performance studiesviene utilizzata per esplorare la propria cultura e i propri comportamenti, spostando lo sguardo dall’esotico all’endotico. Questo tipo di osservazione/studio, che implica simultaneamente la partecipazione diretta e il distacco critico nei confronti dell’oggetto d’indagine o di sé stessi, stimola la revisione, la presa di coscienza e il riconoscimento del fatto che le condizioni sociali e il sapere performativo di una persona non sono sempre fissi, ma rappresentano l’oggetto di verifiche e revisioni, un processo che Schechner individua come un continuo “processo di prove”.
Infine, la quarta direttrice dei performance studies consiste nella loro partecipazione attiva ai processi e alle rivolte sociali. Molte studiose e studiosi dei performance studies non cercano affatto di mantenersi ideologicamente neutri. Anzi, una delle premesse teoriche fondamentali della disciplina è che nessun approccio o atteggiamento possa — o debba — essere neutro, poiché nel comportamento umano non esiste nulla di veramente imparziale. La sfida consiste piuttosto nel coltivare una consapevolezza critica del proprio posizionamento rispetto agli altri, e nel decidere responsabilmente se mantenerlo o trasformarlo. Ad esempio, il nuovo materialismo studia la complessità della continua materializzazione del mondo e il suo cambiamento paradigmatico come produzioni di sapere e posizionamenti etici riguardanti i problemi ecologici, bellici, di violenza e lutto. Questo approccio si concentra sulle significazioni e rappresentazioni che mirano a intrecciare politicamente natura e vita dalle prospettive postcapitaliste, postumane e postcoloniali. Ne consegue la necessità di un’etica capace di assumere piena responsabilità delle nostre azioni nel mondo. Come osserva Hannah Arendt, arti performative e politica condividono un elemento essenziale: entrambe si manifestano nello spazio pubblico come forme di esposizione e di intervento nella realtà condivisa. Arendt paragona l’attività artistica alla prassi politica, evidenziando come la piazza pubblica (agorà) e la scena teatrale rappresentino entrambe spazi di azione. Tra questi due spazi esistono numerose correlazioni, come la co-presenza corporea degli esseri umani, i contatti e la prossimità fisica, che conferiscono una dimensione politica.
Le arti che non realizzano alcuna “opera” hanno grandi affinità con la politica. Gli artisti che la praticano – danzatori, attori, musicisti e simili – hanno bisogno di un pubblico al quale mostrare il loro virtuosismo, come gli uomini che agiscono (politicamente) hanno bisogno di altri alla cui presenza comparire: gli uni e gli altri, per “lavorare” hanno bisogno di uno spazio e struttura pubblica, e in entrambi i casi la loro “esecuzione” dipende dalla presenza altrui.
H. Arendt, La crisi della cultura: nella società e nella politica, in Tra passato e futuro, Garzanti, Milano 2017.
Tuttavia, come sottolinea Arendt, non si tratta di una definizione in senso stretto, bensì di una metafora — che rischia però di diventare fuorviante se si commette l’errore di considerare lo Stato o il governo come opere d’arte, come un presunto “capolavoro collettivo”. La politica istituzionale, infatti, resta strutturalmente estranea — se non contrapposta — alla logica dell’arte. Infatti secondo Arendt, nel corso del Novecento, scrittori, filosofi, artisti e altri intellettuali hanno potuto accedere alla sfera pubblica solo in periodi di rivoluzione, e il movimento dell’arte moderna stesso ha avuto origine da una fervida ribellione degli artisti contro le stesse società costituite. Nonostante questa posizione marginale, esistono ancora artiste e artisti che utilizzano la performance come strumento di critica radicale contro varie forme di oppressione, guerre, razzismo, patriarcato, femminicidi, tardo capitalismo e crisi ecologiche. Regina José Galindo, Coco Fusco, Piotr Pavlenskij, Selma Selman, Tania Bruguera, Shirin Neshat, Ron Athey, Tanja Ostojić, Daniela Ortiz, Susana Pilar, Kader Attia, Gabrielle Goliath e altre/i sono tutte/i artiste/i in cui la praxis e la poiesis mirano a produrre cambiamenti nelle società in cui vivono, soprattutto attraverso azioni corporee non discorsive. La performance art introduce una nuova ecologia delle arti, spostandosi dall’estetico e l’impersonale all’autobiografico e l’etico. Secondo Bonnie Marranca, in La performance. Una storia personale, in American performance 1975-2005, a cura di Valentina Valentini, se un tempo la musica era la forma artistica più alta e di riferimento, oggi è la performance art a porsi al centro del sistema delle arti, sia come ontologia sia come gesto che prende forma nello spazio e sulla scena.